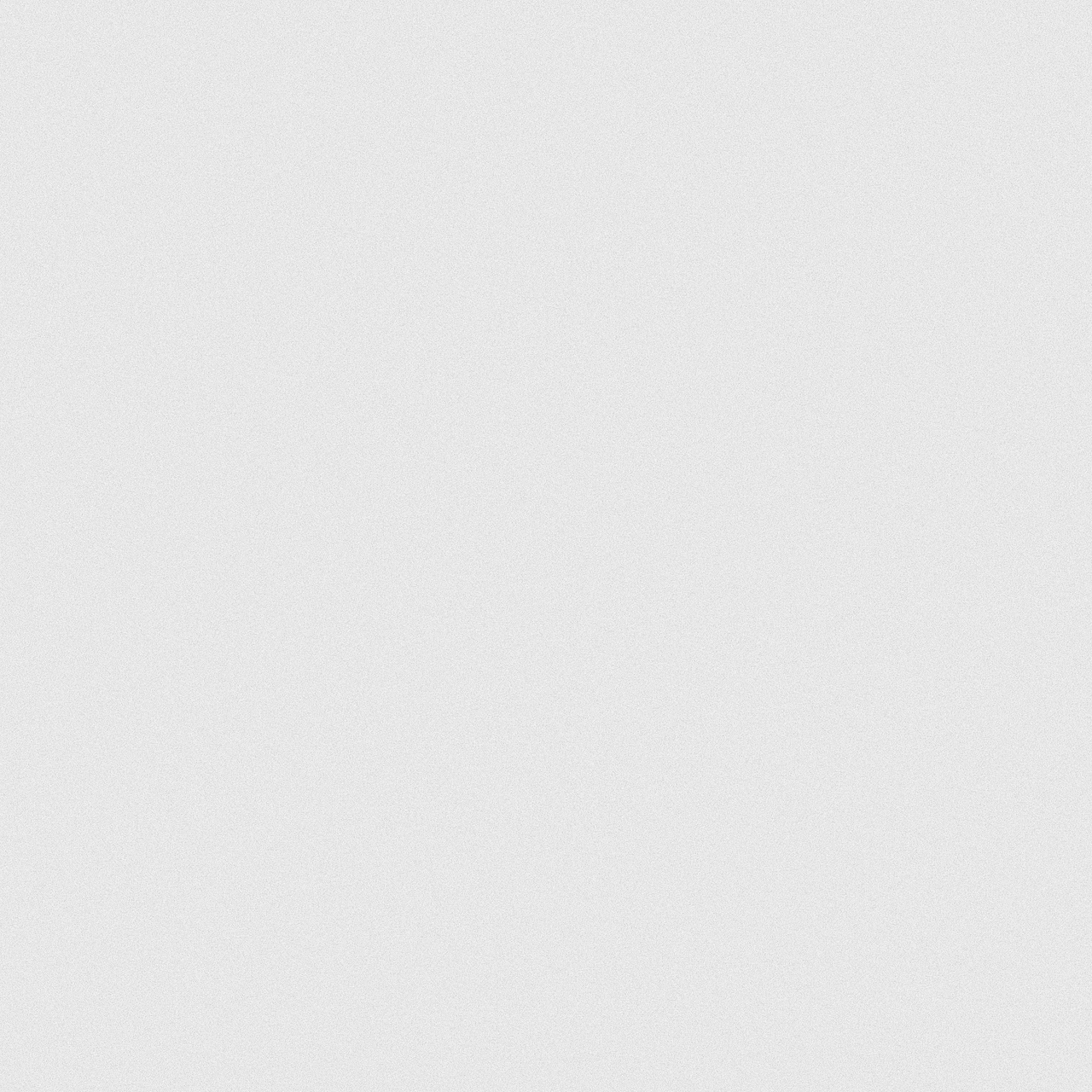
dott. Giuseppe Di Marco
Specialista in malattie respiratorie
Diagnosi e cura delle malattie allergiche

"II vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui s'accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di fiori d'altre terre".
Italo Calvino - Marcovaldo - 1963
LA TUBERCOLOSI NELLA LETTERATURA RUSSA

E’ stato Lev Tolstoj il primo che, coronando un suo perdurante interesse per il tema, ha meditato sulla morte dignitosa e su quella indegna, sul miserevole crepare degli uomini ricchi e sulla fine piena di dignità della povera gente, sulla morte degli uomini e su quella degli alberi. Nella novella “Tre morti” (1859) ambientata in una stazione di posta, racconta la morte tormentata di una lagnosa e petulante signora borghese tisica, desiderosa di andare in Italia e che si lamenta del marito che non l’ha ancora portata all’estero. Poi quella serena un vecchio postiglione chiuso nel suo dignitoso silenzio. E infine la morte perfettamente armonica di un albero abbattuto dagli uomini, ritenuta metafora dell'atteggiamento ideale e nobile di fronte alla sofferenza e la morte.
Incrociando le mani in grembo e chiudendo gli occhi, la signora ondeggiò debolmente sui cuscini adagiati dietro la schiena e, leggermente accigliata, tossì internamente. In testa aveva un berretto da notte bianco e un fazzoletto blu legato intorno a un collo delicato e pallido. Una riga dritta, passando sotto il berretto, divideva i capelli castano chiaro, estremamente piatti, unti, e c'era qualcosa di rinsecchito, mortale nel candore della pelle di questa spaziosa riga. La pelle flaccida, alquanto giallastra, ricadeva sui i contorni sottili e belli del viso e sulle guance e gli zigomi rossi. Le labbra erano secche e irrequiete, le ciglia rade non si arricciavano e il cappuccio di stoffa tracciava linee rette sul petto incavato. Nonostante avesse gli occhi chiusi, il viso della padrona esprimeva stanchezza, irritazione e sofferenza abituale.

Nei “Fratelli Karamazov” Dostoevskij crea il personaggio del piccolo Iljuša, un bambino spesso deriso e maltrattato dai suoi compagni e che alla fine del libro muore di tisi nel contesto di estrema povertà in cui versa la famiglia. Durante le ultime settimane della malattia del ragazzo, Alëša Karamazov, il personaggio positivo del romanzo, piano piano riesce a portare i compagni a riconciliarsi con Iljuša e fargli visita nella sua casa:
Il ragazzino giaceva coperto dal suo cappottino e da una logora trapunta imbottita. Evidentemente non stava bene e, a giudicare dagli occhi lucidi, doveva avere la febbre.
E poi quando chiedono al padre delle sue condizioni di salute:
«E come sta lui, Iliuša, voglio dire?»
«Ah, male, male! Penso che abbia la tisi. È perfettamente cosciente, solo che respira così, respira a fatica. L'altro giorno ha chiesto che gli infilassero gli stivali e lo accompagnassero a fare due passi, ha tentato di camminare, ma è caduto. Ha detto: "Ah, te l'avevo detto, papà, che quegli stivaletti non sono buoni, anche prima facevo fatica a camminarci". Pensava che fosse colpa degli stivali se non si reggeva in piedi, ma è per la debolezza. Non sopravvivrà un'altra settimana…….».
Nell’ultimo capitolo del romanzo Dostoevskij racconta invece il funerale di Iljuša. Dopo il funerale Alëša rivolge un discorso ai ragazzi per spiegare loro l’importanza per la loro vita dell'esperienza fatta, del ruolo dell'amicizia nella crescita di ognuno di loro:
«Per quanto possiamo diventare cattivi – che Dio non voglia – quando ricorderemo il giorno in cui abbiamo sepolto Iljuša, come lo abbiamo amato negli ultimi giorni della sua vita e come, in questo momento, ci siamo parlati da amici, allora anche il più cattivo fra di noi non oserà, dentro di sé, ridere di quanto è stato buono e nobile in questo momento! Potrebbe accadere che proprio questo ricordo lo distolga da un grande male ed egli potrà riflettere e dire: “Sì, allora ero buono, coraggioso e onesto”»
Sì, è proprio vero: nello spazio dell’amicizia possiamo davvero fare esperienza e capire di essere meglio di quanto ci ritenevamo, esperienza che ci conferisce irrimediabilmente un volto nuovo.

In questo racconto dal titolo cupamente evocativo de “Il monaco nero”, è rappresentata alla perfezione l’idea di Anton Chechov: l’uomo è già di per sé condannato al fallimento e all’impotenza perché ingabbiato in un sistema di forze più potente di lui ed è destinato a dissolversi e scomparire, con risvolti pietosamente patetici se il tutto è paragonato all’efficienza della morte. Ovviamente la morte per tubercolosi.
Tutta la vita dell’uomo si gioca sulla dicotomia normalità/follia che rimanda al conflitto tra libertà e controllo, tema oggi più che attuale.
A Kovrin, il protagonista, brillante scienziato, viene in visione il leggendario “monaco nero” che lo esorta a continuare nella sua opera di ricerca scientifica per il bene dell’umanità:
Sei uno dei pochi che a ragione si chiamano eletti di Dio. Tu servi la verità eterna. I tuoi pensieri, i tuoi propositi, la tua straordinaria cultura e tutta la tua vita recano su di sé un’impronta divina, celeste, poiché sono consacrati al razionale e al sublime, cioè a ciò che è eterno.
Ma dopo poco tempo, la moglie lo scopre a parlare con il monaco nero, in realtà da solo, e lo convince a curarsi. La cura è efficace, ma Kovrin perde tutto il suo smalto, l’entusiasmo e la voglia di andare avanti:
Ero impazzito, ero megalomane, ma in compenso ero allegro, attivo, addirittura felice, ero interessante e originale. Adesso sono diventato più ragionevole e più posato, ma in compenso sono come tutti gli altri: sono una mediocrità, la vita mi è noiosa... Oh, come avete agito crudelmente con me! Avevo allucinazioni, ma a chi davano fastidio? Vi domando: a chi davano fastidio?
Il destino è segnato e la famiglia, la professione e la vita di Kovrin vanno in rovina, e infine si ammala di tubercolosi, cosa che lo condurrà a morte. Il Monaco nero gli farà visita per l’ultima volta, in punto di morte, accusandolo di non aver creduto in lui, e tutto sommato, in sé stesso:
«Perché non mi hai creduto?» domandò con aria di rimprovero, guardando tenero Kovrin. «Se allora avessi creduto che sei un genio, questi due anni non li avresti passati in modo così triste e misero.»
Il monaco nero è certamente un'opera autobiografica. L'eccitazione mentale che tormenta e contemporaneamente rende felice il protagonista è simile all'eccitazione mentale dell'autore, come pure la tubercolosi che uccide il protagonista è la stessa patologia di cui soffriva Čechov e che lo porterà a morte. Ecco come è descritta la morte di Kovrin, la morte di un tisico per emottisi:
Kovrin credeva già di essere un eletto da Dio e un genio, gli vennero in mente nitide tutte le conversazioni precedenti col monaco nero e voleva parlare, ma il sangue gli uscì dalla gola dritto sul petto e lui, non sapendo che fare, si passava le mani sul petto e i polsini gli si intrisero di sangue. Voleva chiamare Varvara Nikolaevna che dormiva dietro il paravento, fece uno sforzo e disse:
«Tanja!»
Cadde a terra e, sollevandosi sulle braccia, chiamò di nuovo:
«Tanja!»
. . . . . . . . . .
Chiamava Tanja, chiamava il grande giardino con i fiori lussureggianti spruzzati di rugiada, chiamava il parco, i pini con le radici pelose, il campo di segale, la sua scienza miracolosa, la sua gioventù, il coraggio, la gioia, chiamava la vita, che era così bella.
Vide sul pavimento vicino alla sua faccia una grande pozza di sangue e dalla debolezza non riusciva più a dire nemmeno una parola, ma una felicità inesprimibile, senza limiti riempì tutto il suo essere. Da basso, sotto il terrazzo, suonavano una serenata, e il monaco nero gli sussurrò che lui è un genio e che muore solo perché il suo debole corpo umano ha perso l’equilibrio e non può più fare da involucro a un genio.
Quando Varvara Nikolaevna si svegliò e venne fuori dal paravento, Kovrin era già morto, e sulla sua faccia era rimasto impresso un sorriso beato.