top of page
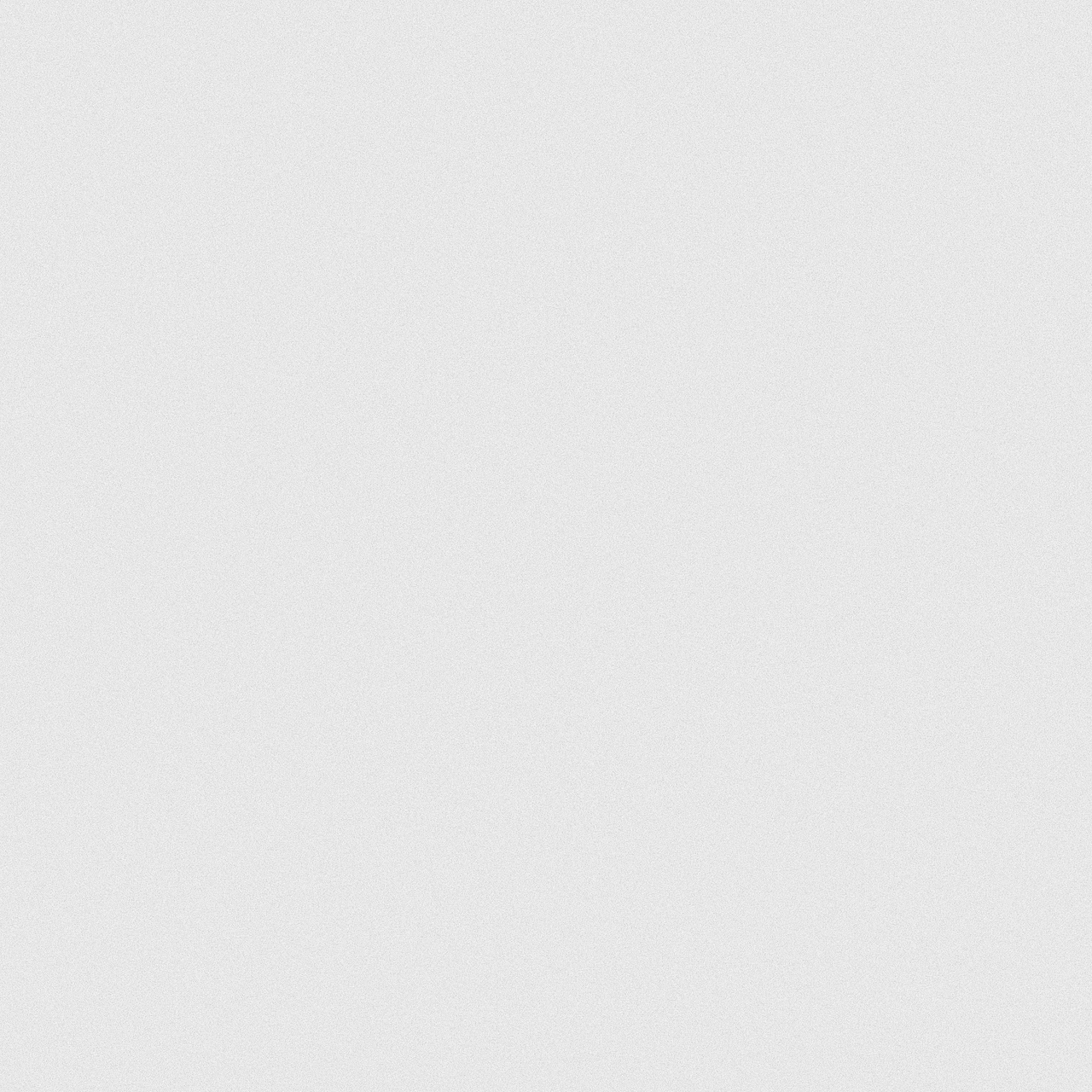
dott. Giuseppe Di Marco
Specialista in malattie respiratorie
Diagnosi e cura delle malattie allergiche

"II vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui s'accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di fiori d'altre terre".
Italo Calvino - Marcovaldo - 1963

Probabilmente nessuno scrittore del Novecento europeo ha fatto della malattia un mito letterario quanto Thomas Mann. Egli ha metaforizzato due flagelli epidemici: il colera, che raggiunge l’Europa solo nel XIX secolo proveniente dall’Asia, e la tubercolosi, le cui caverne polmonari, divengono emblema di un male “intellettuale”, segno dell’acume della mente a detrimento del corpo, e figura di una “diversità” sociale.
Nel racconto lungo La morte a Venezia (1912) il desiderio stesso di un viaggio nella città lagunare nasce nell’anziano protagonista, lo scrittore Von Aschenbach, “come un attacco di malattia”: Venezia, dalla tolda del traghetto imperiale proveniente da Pola, lo accoglie avvolta in un’”afa senza sole”, in una nebbia appiccicosa, equivoca e torbida, che preannuncia il colera. Le autorità cittadine tengono segreta l’epidemia finché possono, per salvaguardare “la grande e multiforme industria del turismo”. ma, col favore dalla canicola, “si sono già inquinati i generi alimentari”. A fronte dell’incombere del colera secco, all’Hotel des Bains del Lido il senile Aschenbach vive una grottesca passione per il ragazzino Tadzio, il cui sguardo docile e disarmante e il cui corpo fragile e malaticcio travolgono ogni impalcatura razionale dell’uomo di cultura, lo inducono a sognare una regressione selvaggia e tribale. In balìa del suo demone, l’intellettuale si sottopone a cosmesi per coprire con uno strato posticcio i segni della vecchiaia, e insegue e spia senza più ritegno il bambino per le calli veneziane “dove vagava dissimulata la morte oscena”. Finché, morente per il colera, assiste sulla spiaggia del Lido a una rissa sulla sabbia, in cui l’oggetto del suo desiderio viene sottomesso nella lotta, con crudele violenza, da un ragazzo più robusto.




Il grande romanzo-saggio La montagna incantata (1924) ha un titolo probabilmente tratto da Nietzsche: “Ora si apre a noi il monte magico dell'Olimpo e ci mostra le sue radici”. Per Nietzsche, il monte dell'Olimpo era il mondo di Apollo: il mondo della violenza e delle tenebre, miracolosamente capovolti in armonia ed equilibrio.
Tra le due rappresentazioni di malattie c’è tuttavia di mezzo la violenza della storia che divide nettamente le acroniche sofferenze del corpo umano. La montagna incantata è separata da Morte a Venezia dall’ecatombe della Prima Guerra Mondiale. Hans Castorp, giovane borghese in formazione, va a trovare il cugino ricoverato ma si ammala a sua volta di tisi e non si stacca per sette anni dal sanatorio svizzero di Davos, microcosmo sociale in sé completo, dove il giovane può intraprendere un’educazione sentimentale (grazie a una malata, Madame Chauchat) e intellettuale.
Qui la malattia è ad un tempo, ambiguamente, degenerazione e rigenerazione.
Razionalità illuministico-borghese e irrazionalismo totalitario si combattono nel sanatorio, come gemelli esangui, tramite le voci di due ospiti del luogo di cura, tra loro divisi in una lotta mentale: l’umanista Settembrini e il gesuita Naphta. Sono due figure che allegorizzano, in forma di degenti tubercolotici, l’intera vicenda della moderna cultura europea. La ragione del progresso si esprime mediante l’accumulo discorsivo di Settembrini, le istanze opposte tendono invece all’ombra e al silenzio. L’equilibrio, l’”incanto” del microcosmo pedagogico montano, si rivelano un’illusione: sono destinati infatti ad andare in pezzi con lo scoppio della Grande Guerra. Lasciata la montagna, Castorp, come migliaia di giovani intellettuali europei, si trova coinvolto nel macello mondiale.
Il Sanatorio Internazionale Berghof è abbastanza chiaramente un’allegoria della cultura europea con le sue contraddizioni, i suoi vizi, la sua decadenza, le sue malattie: c’è il borghese arrivista, il reazionario moralista, il voltairiano anticonformista ma non troppo; ci sono il materialismo, il Romanticismo e la psicoanalisi nascente; ci sono infine pacifismo e militarismo alla vigilia della tragedia immane della I Guerra Mondiale. C’è tutto di un’epoca, forse troppo - non vorrei sembrare eretico, ma oggi un manoscritto del genere nelle mani di un editor sarebbe stato profondamente snellito - l’istantanea struggente del tramonto della Belle Époque e dell’avvento della modernità: rumorosa, sanguinaria, perversa, efficiente, frenetica, spietata.
Mann, nella rappresentazione metaforica della malattia, assume dunque come mito letterario la lezione di Nietzsche che condensava nel concetto di “corpo” tutto il rimosso della ragione cartesiana. L’evento della malattia poteva far riemergere il linguaggio del corpo, il più grande dolore poteva provocare il beneficio del sospetto e della folgorazione. Del resto, già nell’Idiota di Dostoevskij il principe Myskin affermava che solo nel momento dell’attacco epilettico, solo nell’istante il cui la malattia si presenta improvvisa e vittoriosa, “si può dare tutta la vita”.
Come Ascenbach in La morte a Venezia anche Hans Castorp parte per una “vacanza” e l’ambito di tale vacanza è una dimensione fatale nell’esistenza dell’individuo, che fa emergere dalle profondità della psiche tendenze e pulsioni che ne sconvolgono le strutture apparentemente consolidate. La Venezia esotica e corrotta dal colera lascia spazio al sanatorio dove, dietro elementari appetiti erotici e gastronomici, si muore nelle mutevoli forme devastatrici assunte dalla tubercolosi.
La morte e la malattia in ambedue i romanzi si intrecciano ai ritmi e ai tempi della natura: il ritmo sempre uguale del mare in La morte a Venezia e l’eterno presente privo di stagioni de La montagna incantata.
“L’unico modo sano, nobile, religioso, di considerare la morte è di concepirla e di sentirla come parte integrante, come complemento, come sacra condizione della vita, ma non di scinderla in qualche modo spiritualmente dalla vita, di porla in contrasto, di farne cosa ripugnante ad essa.”
La malattia dunque subentra alla salute ma anche alla produttività borghese che entra decisamente in crisi. In La morte a Venezia le virtù borghesi di Ascenbach erano giunte ad uno stato di tale sublimazione da diventare fragili e periture, ne La montagna incantata il disgregarsi della realtà borghese si manifesta nel comportamento dei malati che – nell’ambito del sanatorio – non si muovono , rimangono sempre uguali a loro stessi e chiusi nel ritmo immutabile delle giornate all’insegna della staticità e dell’improduttività!
Ed è sempre la malattia a costituire la dimensione fatale nella vita dei personaggi dei due romanzi di Mann: ne La morte a Venezia lo scrittore Von Ascenbach non riuscirà a lasciare una Venezia infettata dalla peste pur di restare accanto all’amato Tadzio, ne La montagna incantata la malattia diventa addirittura un prezioso pretesto del quale Castorp “si serve” per trattenersi nel sanatorio e non separarsi da Clawdia, la donna ricoverata di cui egli si innamora perdutamente.
E’ così che i due eroi di Thomas Mann vengono sequestrati inaspettatamente dal loro destino!
Quando, nelle ultime pagine de La montagna incantata il lettore è chiamato ad abbandonare il tempo e lo spazio separati e sospesi della montagna e della malattia e a scendere con Castorp in pianura, ad affrontare il tempo della storia, si imbatte infatti in un orrore e in un male definitivi, del tutto ingovernabili con gli strumenti mentali della cultura, della filosofia e della letteratura:
"Dove siamo? Che cos’è questo? Dove ci ha gettati il sogno? Luce crepuscolare, pioggia, immondizie, bagliori d’incendio nel cielo grigio, continui rimbombi nell’aria umida, rotta da canti aspri, da ululati furibondi e infernali che terminano la loro traiettoria con scoppi, spruzzi, fragori e schianti. (…) Ci troviamo in pianura e c’è la guerra."


bottom of page