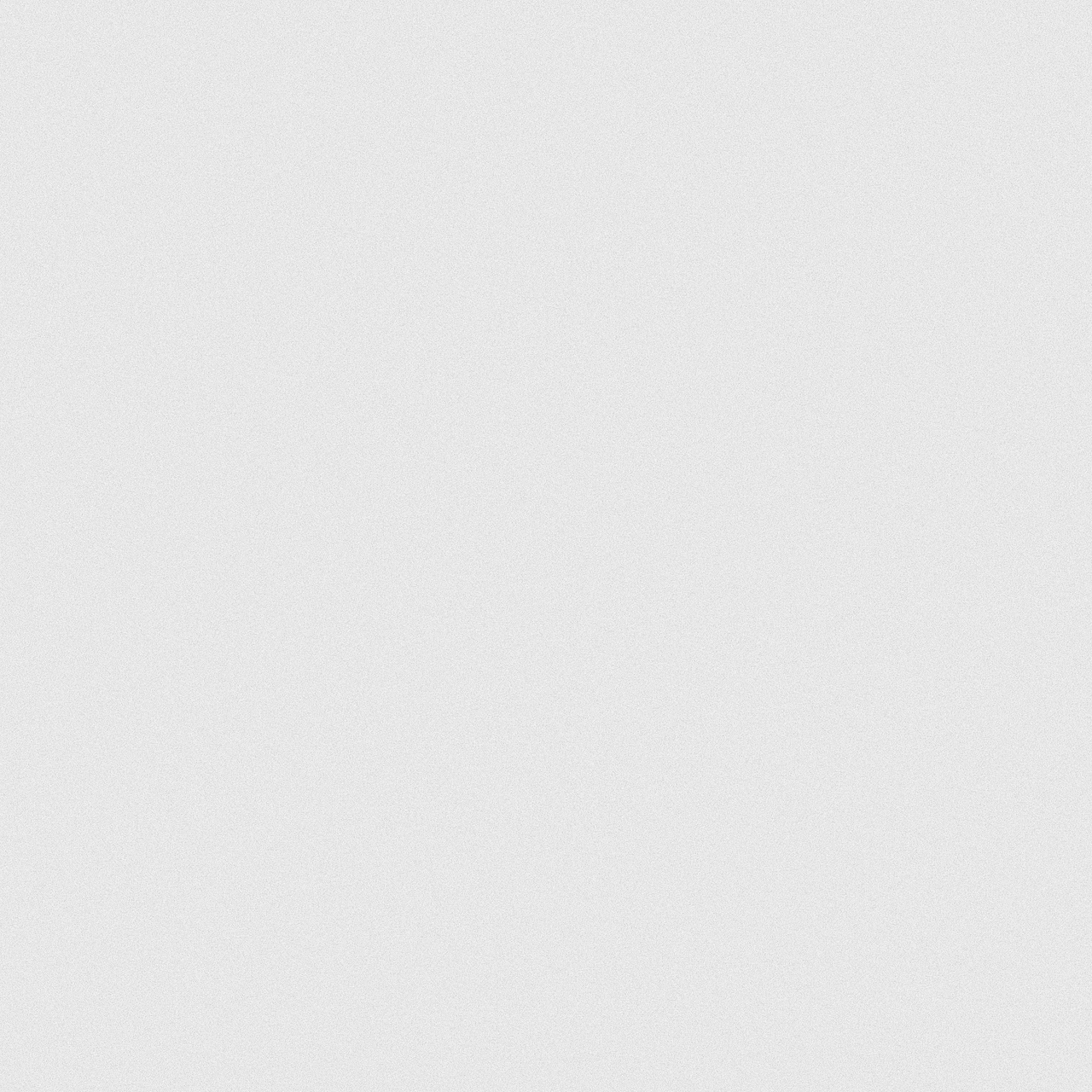
dott. Giuseppe Di Marco
Specialista in malattie respiratorie
Diagnosi e cura delle malattie allergiche

"II vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui s'accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di fiori d'altre terre".
Italo Calvino - Marcovaldo - 1963
la Tubercolosi nel Romanticismo e Verismo in Italia

Pochi anni più tardi, nel 1840, viene pubblicato "Fede e bellezza" di Niccolò Tommaseo, letterato, scrittore e poeta coerentemente romantico. Il romanzo narra la storia di Giovanni e Maria, due personaggi incerti, contraddittori, tormentati.
Conosciutisi a Quimper, in Francia, i due si innamorano e cominciano a confidarsi il loro passato, soprattutto le loro esperienze amorose. Superati conflitti e tentazioni, dopo esistenze fitte di delusioni, i due si sposano e, anche durante il matrimonio, continuano a confidarsi ogni più piccolo moto dell'anima, trovando finalmente una qualche serenità. Nel finale Giovanni rimane ferito durante un duello con un francese che ha insultato l'Italia; riesce a guarire, ma solo per assistere dolorosamente alla malattia di Maria e alla sua morte, a causa della tisi.
“Una notte di dicembre fredda e piovosa (eran le undici sonate, e il fuoco del caminetto già spento), Maria pregata, non voleva smettere prima di finire il lavoro. Giovanni le si accosta quasi supplichevole: e stava per baciarla in fronte, quando s’accorge di non so che rosso sul volto suo più pallido e più soavemente mesto che mai. Mentre guarda spaventato, Maria ritira in fretta la pezzuola che aveva sul grembiule; egli trepidando gliela prende, la trova intrisa di sangue e mette un grido.”
La tubercolosi non perdona e Maria morirà dopo sofferenze che, secondo l’ideologia romantica ben espressa da Tommaseo, purificheranno sia lei, dopo una vita che non ha escluso il peccato, sia Giovanni che ne condivide il calvario:
“Il male ripigliava con furia: le febbri talvolta la levavan di sé; e nel delirio vedeva cosa pietose, e quando liete, ch’erano più di tutte pietose a sentire. La notte del dì ventun dicembre vaneggiò lungamente. Il dì ventidue peggiorò.”
Fede e bellezza - 1840
Niccolò Tommaseo


Prima della completa adesione al verismo, e lo spostamento dell'asse tematico dalla sfera sentimentale alla"religione della roba", anche Giovanni Verga descrive il mondo frivolo e brillante dei salotti che era stato al centro dei romanzi mondani, ma il gioco della seduzione appare ormai disperatamente frivolo e vuoto. Nella novella "Dramma intimo" scritta precedentemente ma pubblicata nei "Drammi ignoti" nel 1884, una madre rinuncia al suo segreto amante per cederlo alla figlia gravemente ammalata di tisi e che vede quasi morire d'amore. La giovane guarisce ma è la madre che si ammala, e ne muore.
La contessina Bice è ormai resa inferma da una malattia che non accenna a guarire, nonostante le amorevoli attenzioni della madre. Un giorno il medico, visitando l’ammalata, intuisce che la ragazza è innamorata del marchese Danei, che in realtà è l’amante della madre, e sostiene che se questi la chiedesse in sposa ella molto probabilmente guarirebbe.
"Casa Orlandi era tutta sossopra. La contessina Bice spegnevasi lentamente: di malattia di languore, dicevano gli uni: di mal sottile, dicevano gli altri.Nella gran camera da letto, quasi buia in tutto il quartiere illuminato come per una festa, la madre, pallidissima, seduta accanto al letto dell'inferma, aspettava la visita del dottore, tenendo nella mano febbrile la mano scarna e ardente della figliuola, parlandole con quell'accento carezzevole, e quel falso sorriso con cui si cerca di rispondere allo sguardo inquieto e scrutatore dei malati gravi."
. . . . .
- Come ha trovato stasera la mia ragazza? Mi dica la verità!-
- Nulla di nuovo, - rispondeva lui. - La solita febbriciattola... il solito squilibrio nervoso... - La solita pozione per questa notte, - continuò il medico quasi avesse dimenticato la sua domanda. - Bisogna osservare a che ora cadrà la febbre. Del resto, nulla di nuovo. Diamo tempo alla cura...
A questo punto la contessa Anna decide di sacrificare il suo amore per l’uomo per il bene della figlia e lo convince, seppur a fatica, a sposare Bice, anche se non la ama. Verga così narra i mali dell'animo umano:
La madre scrutava quel viso pallido e impenetrabile con uno sguardo ardente, arrossendo e impallidendo a vicenda.
A un tratto si fece smorta come lei, e la chiamò con un'altra voce:
- Bice!
Il suo petto si contraeva spasmodicamente, come se qualche cosa vi agonizzasse dentro. Poscia si chinò sulla figliuola, posando la guancia febbrile su quell'altra guancia scarna, e le mormorò nell'orecchio, con un soffio appena intelligibile:
- Senti, Bice... tu ami?...
Bice spalancò gli occhi all'improvviso, tutta una fiamma in volto. E con quegli occhi sbarrati e quasi paurosi, affascinati dagli occhi lagrimosi della madre, balbettò con un accento ineffabile d'amarezza, e quasi di rimprovero:
- Oh mamma!... -
Come previsto, il matrimonio permette alla ragazza di recuperare la salute e la felicità e i due coniugi si trasferiscono insieme lontano dalla contessa, che nel frattempo si ammala gravemente. Trascorre un periodo a casa di Bice e Danei, e dopo essere diventata nonna, si accorge che sua figlia Bice nutre per lei un sentimento di gelosia:
Bice andava rimettendosi lentamente. Però il suo organismo delicato vibrava ancora. Nei lunghi giorni di convalescenza le venivano dei pensieri neri, degli impeti d'irritazione sorda e irragionevole, degli scoramenti improvvisi, quasi tutti l'abbandonassero. Allora guardava muta, cogli occhi neri, e diceva al marito con accento indescrivibile:
- Dove sei stato? - Dove vai? - Perché mi lasci sola? -
Ogni cosa la feriva; sembrava ingelosirsi anche di quel resto di eleganza ch'era sopravvissuto nella madre sua. Era arrivata a dirle, cercando di dissimulare la febbre che le si accendeva suo malgrado negli occhi: - Quando partirai? -
La madre chinò il capo, quasi sotto il peso di un castigo inevitabile.
Anna vede aggravarsi le sue condizioni e muore proprio il giorno in cui il marchese, saputa la notizia sulla sua salute, si reca a trovarla.

Dopo essere apparsa sul "Fanfulla", nel 1880 Giovanni Verga pubblica "Rosso Malpelo" insieme ad altre novelle nel volume "Vita dei campi". In questo suo primo esempio di verismo, Verga narra la drammatica storia di un bambino, soprannominato Malpelo per i suoi capelli rossi, costretto a lavorare in condizioni durissime nella cava di sabbia in cui suo padre ha trovato la morte. Verga crea un personaggio di straordinario realismo psicologico: un bambino costretto a crescere troppo in fretta, che, privo dell’affetto della famiglia e di veri amici, accetta con orgogliosa rassegnazione il suo destino di “vinto”. Con lui, un giorno, verrà a lavorare Ranocchio, ragazzino zoppo e malaticcio. Malpelo che da un lato lo aiuta e lo protegge, dall'altro lo picchia e lo maltratta con lo scopo di insegnargli a vivere in quel mondo così duro e crudele. Ma poco dopo Ranocchio, ammalatosi di tubercolosi e stremato dalla fatica, muore.
Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera doveva portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcino bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per riuscire a lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi.
Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male …
Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni.. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata.
Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: – È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo.
Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo.
… Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul letto. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: – È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi!
Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio (i resti dell'asino n.d.r.), nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così.
Rosso Malpelo
in "Vita dei campi" - 1880
Giovanni Verga

“Le bevitrici di sangue”, tratto da "Mattinate napoletane" (1886) di Salvatore Di Giacomo, scrittore vissuto tra l’Ottocento e il Novecento, descrive perfettamente uno spaccato di vita quotidiana di Napoli, legato anche alle condizioni sanitarie: il macabro rituale delle bevitrici di sangue per risolvere l’anemia. Di Giacomo, d’altro canto, era un ex studente di Medicina, quindi in parte esperto dell'argomento, che aveva abbandonato la professione voluta dal padre per dedicarsi al lavoro di redattore di giornale.
"Dalle sette e mezzo della mattina fino alle dieci la carneficina delle vacche, al macello di Poggioreale, si compie tra uno strano affollamento di bevitrici di sangue, dura tra i desideri sanguinosi delle anemiche, delle clorotiche, delle povere fanciulle sbiancate in faccia come la cera.
Esse accostano alle pallide labbra il bicchiere colmo di quello spumante "vin delle vene" e bevono d'un fiato, socchiusi gli occhi, la mano che leggermente trema".
".... ma prima, appena l'animale piega le gambe e si rovescia sul dosso, il fornitore di sangue, scalzo, sguazzanti i piedi nel sangue, accosta alla viva fontanella il bicchiere e, correndo, lo porta alla fanciulla anemica. E costei beve d'un subito fino all'ultimo gocciolo, e le labbra e il mento le si dipingono d'un rosso fortissimo, e le dita si sporcano, e gli anellini luccicano tra il sangue gocciante".
Le bevitrici di sangue
in "Mattinate napoletane" - 1886
Salvatore Di Giacomo